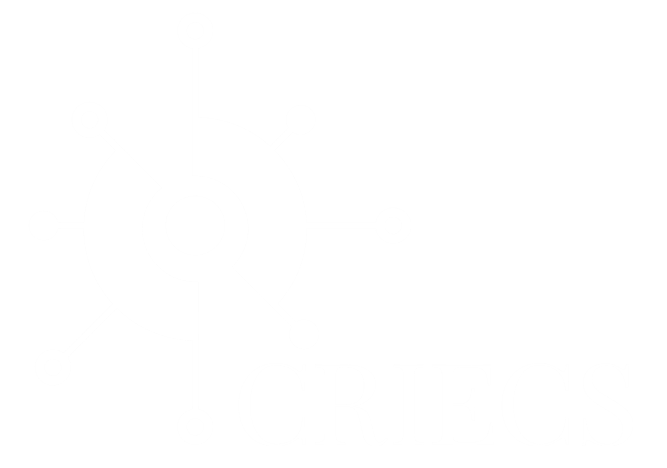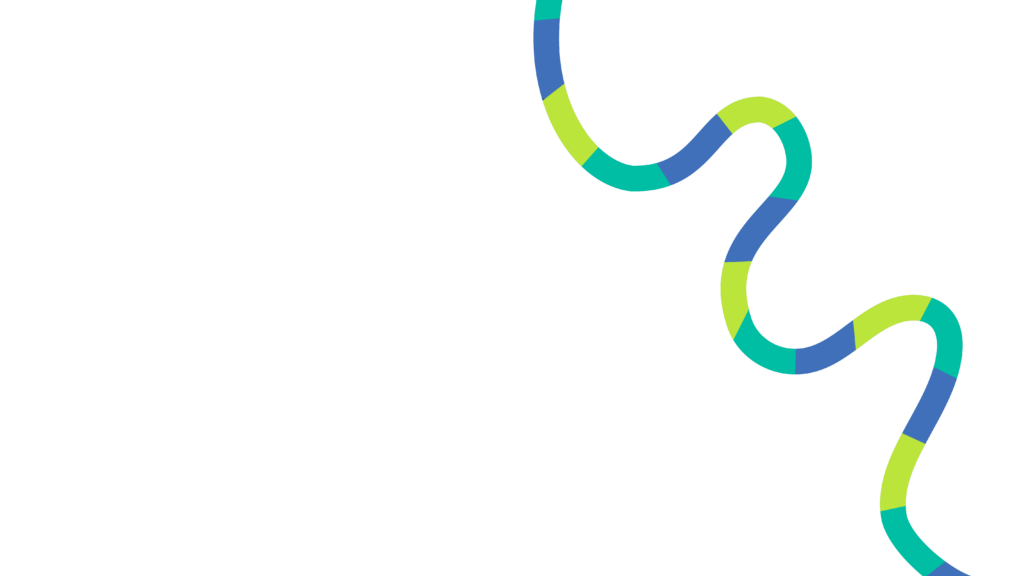Fonte: Il Sole 24 ore
Uno dei temi centrali discussi durante il 74° Nobel Laureate Meeting, tenutosi a Lindau, in Germania, nel luglio 2025 è stato il ruolo della chimica nel fronteggiare la crisi ambientale, attraverso l’adozione di approcci innovativi e sostenibili. La discussione ha coinvolto decine di Premi Nobel e centinaia di giovani scienziati, sottolineando l’urgenza di ridefinire i modelli operativi della ricerca scientifica in funzione della sostenibilità ambientale.
Il primo nucleo tematico trattato riguarda la necessità di una revisione critica dell’eredità chimica del passato. Se da un lato la chimica ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo industriale e tecnologico del XX secolo, dall’altro ha prodotto sostanze e materiali altamente persistenti, spesso non biodegradabili, che si accumulano nell’ambiente con effetti negativi a lungo termine. È il caso emblematico dei siliconi, materiali onnipresenti ma non riconosciuti dalla natura e quindi non degradabili attraverso processi biologici spontanei.
La professoressa Frances Arnold, Premio Nobel per la Chimica nel 2018, ha illustrato un importante avanzamento in questo ambito: lo sviluppo del primo enzima capace di degradare legami tra gruppi organici e silicio. Questo traguardo rappresenta un primo passo concreto verso l’inversione dei processi industriali, e testimonia l’efficacia di un approccio molecolare bio-ispirato. A tal proposito è stato affrontato il concetto di ingegneria evolutiva degli enzimi, ovvero l’applicazione dei principi della selezione naturale per ottenere biocatalizzatori artificiali con nuove funzionalità. Questo approccio, largamente sostenuto dalla stessa Arnold, consente di progettare enzimi in grado di catalizzare reazioni chimiche in modo più selettivo, pulito ed efficiente rispetto alla chimica tradizionale. Gli enzimi operano a temperatura ambiente, in soluzioni acquose e senza generare sottoprodotti tossici, rendendoli strumenti ideali per la transizione ecologica della chimica.
È da evidenziare come questa strategia non sia solo eticamente auspicabile, ma anche economicamente vantaggiosa. La chimica verde, infatti, può risultare meno costosa e più efficiente in termini di risorse rispetto ai metodi convenzionali.
L’urgenza del cambiamento è stata anche ribadita da Steven Chu, Premio Nobel per la Fisica nel 1997 e ex Segretario all’Energia degli Stati Uniti. Chu ha richiamato l’attenzione sulla già avvenuta superamento della soglia di 1,5 °C di riscaldamento globale e sulla probabilità di raggiungere i 2 o 2,5 °C nei prossimi decenni, richiedendo interventi tempestivi non solo sul fronte scientifico, ma anche su quello politico e tecnologico.
In questo contesto, si colloca l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale (IA) nei processi di ricerca: dalla predizione delle strutture molecolari alla selezione di varianti enzimatiche promettenti, l’IA consente un’accelerazione drastica dello sviluppo scientifico. Tuttavia, Arnold mette in guardia sui rischi legati alla biosicurezza, all’equità nell’accesso agli strumenti e alla necessità di controllo di qualità.
La visione prospettica di Ben Feringa (Nobel 2016) e Stanley Whittingham (Nobel 2019) amplia il discorso verso una chimica progettuale e circolare, capace non solo di imitare, ma in alcuni casi di superare la natura. Feringa immagina futuri sistemi di conversione della CO₂ più efficienti della fotosintesi, mentre Whittingham richiama l’attenzione sulla progettazione di batterie che siano riparabili, durature e riciclabili.
Questi interventi pongono in luce la necessità di ripensare l’intero ciclo di vita dei materiali, superando l’approccio lineare in favore di uno sistemico e rigenerativo
Per concludere è da notare come la chimica stia attraversando una profonda trasformazione, sospinta dalla necessità di rispondere alla crisi ambientale globale. L’adozione di modelli bio-ispirati, l’evoluzione assistita degli enzimi, l’impiego dell’intelligenza artificiale e la progettazione circolare delle tecnologie emergono come le direttrici principali di questa nuova visione.
L’incontro di Lindau rappresenta quindi non solo un momento di confronto scientifico di alto livello, ma anche un segnale simbolico e concreto di un impegno condiviso per una scienza al servizio del pianeta. La chimica del futuro, per essere davvero sostenibile, dovrà imparare a costruire sapendo già come smontare, in un equilibrio tra progresso tecnologico e responsabilità ambientale.